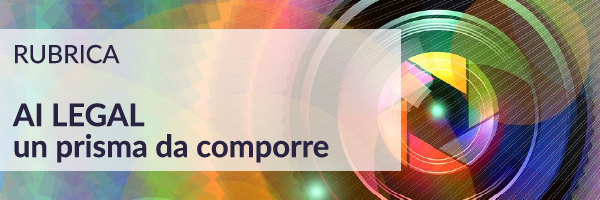Lo scorso 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”; tra i numerosi temi affrontati, il legislatore nazionale non ha dimenticato di richiamare la centralità dell’essere umano nella creazione delle opere intellettuali e di ribadire principi fondamentali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
La tutela dell’autore
Nel sistema tradizionale della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), il diritto d’autore è costruito attorno all’opera e al suo autore umano, tutelando la paternità e l’originalità della creazione.
Sul punto, la Legge 132/2025 si pone in continuità con la tradizione in materia di tutela dell’autore, rafforzando il richiamo al c.d. “principio di riserva di umanità”.
L’art. 25 della Legge 132/2025 interviene sull’art. 1 comma 1 della Legge 633/1941 modificandolo come segue:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.
La paternità dell’opera creata con strumenti di intelligenza artificiale viene dunque riconosciuta all’autore “umano”, laddove lo strumento di IA non abbia di fatto assorbito l’elaborazione creativa dell’autore che se ne è avvalso.
La “riserva di umanità”
- riafferma la centralità dell’essere umano nei processi di creazione, fruizione e conservazione del sapere;
- richiede che ogni decisione automatizzata sia supervisionata da un soggetto umano (“human in the loop”).
Dalla tutela dell’opera alla tutela dell’ecosistema creativo
Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, la tutela si estende anche ai processi di utilizzo, trasformazione e riproduzione delle opere, specialmente quando queste vengono impiegate per l’addestramento o la generazione automatizzata di nuovi contenuti.
In tale contesto, l’impiego proporzionato e trasparente dell’IA non è solo un principio etico, ma un criterio giuridico fondamentale per garantire che la tecnologia non eroda la funzione sociale e culturale del diritto d’autore.
L’IA, infatti, non si limita a riprodurre opere esistenti, ma le assorbe, combina e rigenera, ponendo interrogativi circa la legittimità di tali operazioni alla luce dei diritti esclusivi dell’autore e delle eccezioni culturali previste dalla legge.
La proporzionalità come limite sostanziale all’uso dei dati protetti
La proporzionalità funge da principio-cardine per bilanciare due interessi contrapposti:
- la tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore, sancita dagli artt. 12 ss. L. 633/1941;
- la libertà di ricerca, innovazione e diffusione del sapere, valorizzata dalle eccezioni culturali degli artt. 70-bis e 70-ter.
In particolare:
- l’art. 70-bis consente l’uso, senza scopo di lucro, di opere protette da parte di istituti di istruzione o formazione professionale — anche in ambienti digitali o a distanza — per finalità didattiche e formative, a condizione che tale impiego sia proporzionato allo scopo perseguito e non incida irragionevolmente sui diritti dell’autore;
- l’art. 70-ter consente a biblioteche, musei e archivi di riprodurre o comunicare opere protette per finalità di conservazione, restauro o digitalizzazione, purché l’attività non abbia scopo commerciale diretto o indiretto e rispetti la funzione pubblica della memoria culturale.
Queste disposizioni esprimono un principio di uso equo e proporzionato, oggi estendibile, per analogia funzionale, anche ai processi di addestramento e impiego dell’IA.
La Legge 132/2025, all’art. 25, si inserisce in questa logica, introducendo il nuovo art. 70-septies della Legge sul diritto d’autore, ai sensi del quale:
“1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”.
La nuova previsione normativa non si discosta dunque dal solco della tradizione vietando, di fatto, l’estrazione o la riproduzione non autorizzata di contenuti, dati o altri materiali da opere protette tramite sistemi di IA, salvo che ricorra una finalità riconducibile alle eccezioni di legge di cui agli artt. 70 ter e 70 quater e siano rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
D’altra parte, anche il Regolamento UE 1689/2024 (AI ACT) prevede all’art. 53, comma 1 che
“I fornitori di modelli di AI per finalità generali:
- c) attuano una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790”.
La Direttiva UE 2019/1970 ha previsto le eccezioni di legge di cui al nostro art. 70-ter Legge sul diritto d’autore.
In sintesi, la proporzionalità diventa un criterio operativo: l’uso di opere protette in contesti algoritmici è lecito solo se limitato e di fatto funzionale agli scopi istituzionali dei soggetti (istituti di istruzione, biblioteche, enti di ricerca) autorizzati.
Lo scopo culturale
E’ importante sottolineare che entrambi gli articoli 70-ter e 70-quater della Legge 633/1941 contengono un esplicito richiamo alla necessità che l’uso delle opere protette non abbia fini di lucro o scopi commerciali diretti o indiretti; di fatto è autorizzato il “c.d. uso culturale” delle opere protette.
Richiamando esplicitamente i suddetti articoli, la Legge 132/2025 non fa, palesemente, alcuna concessione a tutti quei soggetti che si appropriano dei contenuti delle opere protette per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale a fini meramente commerciali.
La trasparenza come garanzia procedurale e informativa
A ulteriore salvaguardia dell’essere umano ma anche delle opere, dei dati e delle informazioni utilizzate nello sviluppo dei sistemi di IA, tanto il legislatore nazionale che quello europeo impongono un obbligo di trasparenza, introdotta espressamente dall’art. 3 della Legge 132/2025, che impone obblighi di informazione, tracciabilità e spiegabilità a chi sviluppa e a chi impiega sistemi di intelligenza artificiale, obbligo che diventa più stringente ai sensi dell’art. 53, comma 1 lettera d) dell’AI ACT per i fornitori di modelli di AI per finalità generali, i quali
“redigono e mettono a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello fornito dall'ufficio per l'IA”.
Applicata al diritto d’autore, la trasparenza implica:
- l’obbligo di dichiarare la provenienza dei dataset utilizzati per addestrare o alimentare i modelli di IA, specificando se contengano materiali coperti da diritto d’autore;
- la garanzia, per gli autori o i titolari dei diritti, di accedere a informazioni sull’utilizzo delle loro opere nei processi di elaborazione automatizzata;
- la previsione di meccanismi di tracciabilità e audit algoritmico, idonei a verificare la conformità dell’uso alle eccezioni di cui agli artt. 70-bis e 70-ter.
In assenza di trasparenza, è impossibile stabilire se l’impiego dell’opera sia proporzionato, lecito o abusivo: il principio informativo diventa quindi condizione di legittimità della stessa attività tecnologica.
Verso un diritto d’autore algoritmico e umano-centrico
L’incontro tra gli artt. 70-bis e 70-ter L. 633/1941, la Legge 132/2025 e lo stesso AI ACT disegna un diritto d’autore in evoluzione, in cui la proporzionalità ne definisce i limiti sostanziali, la trasparenza ne assicura la verificabilità, e la riserva di umanità ne garantisce la coerenza con i valori costituzionali.
La nuova architettura normativa porta a una responsabilità tecnologica diffusa, che coinvolge:
- gli sviluppatori di IA, tenuti a verificare che i dataset rispettino il diritto d’autore e le eccezioni culturali;
- gli utilizzatori professionali, che devono impiegare gli strumenti in modo proporzionato e trasparente.
Questa responsabilità collettiva riflette il principio della “riserva di umanità”, assicurando che la tecnologia potenzi, ma non sostituisca, la funzione intellettuale e creativa dell’uomo.
Rubrica "AI LEGAL, un prisma da comporre"
Leggi gli altri articoli presenti nella nostra rubrica dedicata.