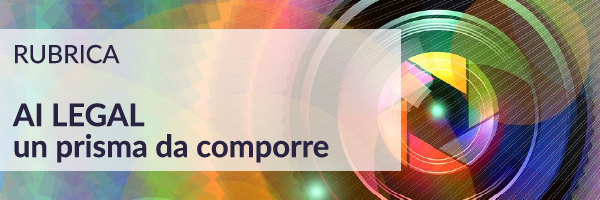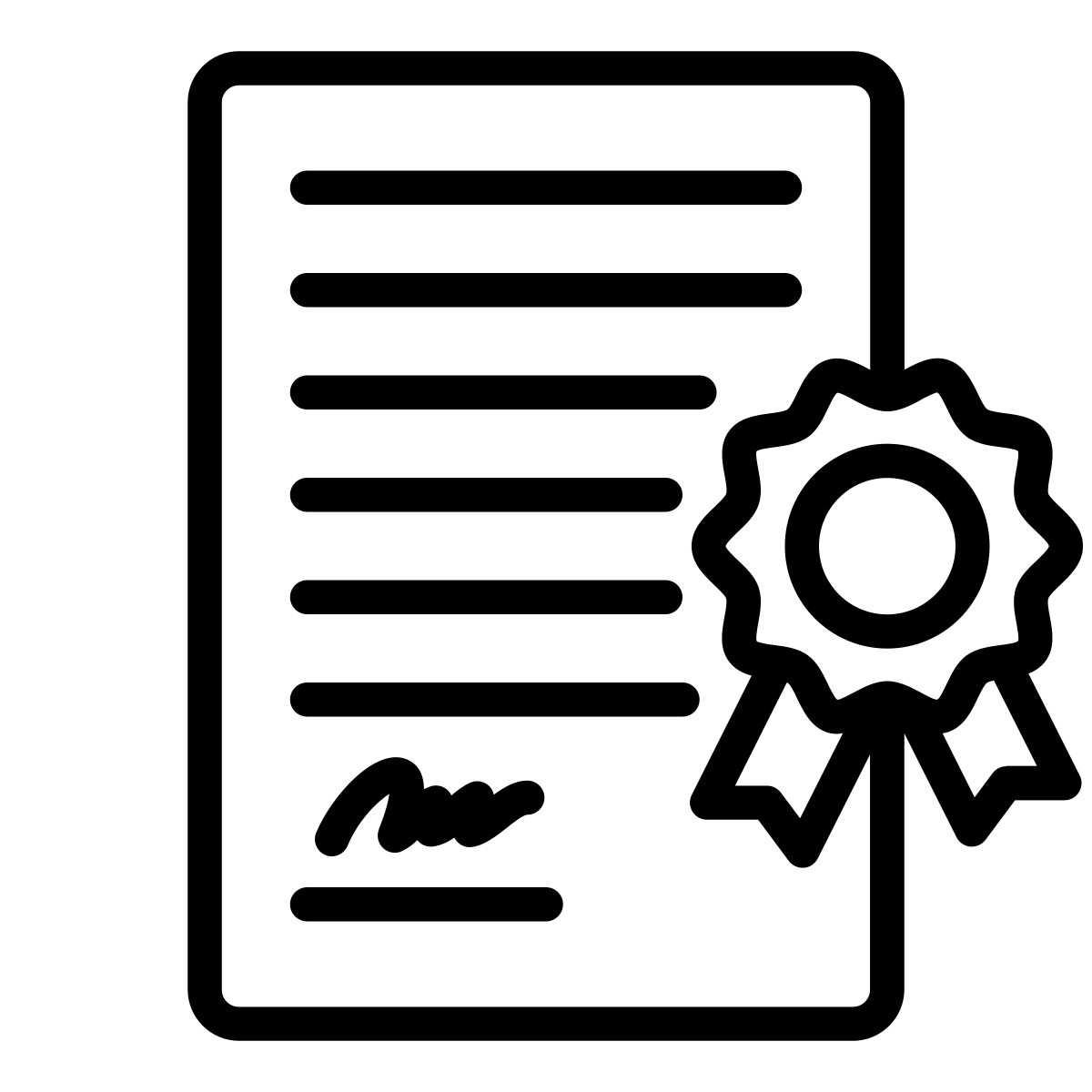 AI e IP Law
AI e IP Law
Nel nostro approfondimento “Tutela della proprietà intellettuale e sviluppo dei sistemi di AI: due posizioni inconciliabili?” abbiamo esaminato il rapporto tra intelligenza artificiale e dati di addestramento in relazione all’uso indiscriminato di informazioni anche coperte da diritti di proprietà intellettuale.
Sempre in tema di rapporti tra AI e proprietà intellettuale, l’altra fondamentale domanda da porsi è se le opere generate tramite un sistema di AI possano considerarsi originali e autonome e, in tal caso, a chi spettino i diritti di proprietà intellettuale.
L’essere umano al centro
La legge italiana sul diritto d’autore (Legge 633/1941 - LDA) prevede all’art. 1 che:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Nell’attuale formulazione della norma non vi è quindi un riferimento al fatto che l’autore debba essere umano, anche se fino ad ora si è di fatto dato per scontato che la presenza dell’essere umano sia richiamata e data per implicita nel concetto di creatività. Non ci può essere creatività senza l’uomo.
La necessità della presenza dell’essere umano viene richiamata tanto nelle decisioni dei giudizi nazionali che in quelle della Corte di giustizia europea, che in più occasioni fa riferimento alla “creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione dell’opera”.
Anche nel diritto anglosassone l’interpretazione delle Corti e del Copyright office del concetto di authorship è sempre legata indissolubilmente all’uomo come persona fisica.
D’altra parte il DDL italiano sull’intelligenza artificiale propone all’art. 24 una modifica all’art. 1 della Legge sul diritto d’autore, il cui nuovo testo dovrebbe essere riformato come segue
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.
Anche in tema di brevetti, il Patent and Trade Mark Office degli Stati Uniti ha emanato la “Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions”, in vigore dal 13 febbraio 2024, in cui viene stabilito che un’invenzione realizzata con l’assistenza di un sistema di AI non è, in quanto tale, non brevettabile ma è necessaria un’analisi approfondita dell’apporto umano, in quanto il brevetto può essere concesso solo a quelle invenzioni il cui apporto umano è significativo.
Ad oggi, quindi, possiamo ancora dire che la tutela della proprietà intellettuale viene riconosciuta esclusivamente all’autore umano, sia che si tratti di diritto d’autore sia che si tratti di proprietà industriale; quindi, è sempre necessario che ci sia un apporto umano significante.
L’apporto in termini di creatività
L’altro elemento rievante riguarda l’effettività del contributo umano, che deve essere creativo, rilevante e dimostrabile rispetto all’apporto dato dalla macchina nella creazione dell’opera dell’ingegno.
Affinché sia riconosciuta la paternità di un’opera al suo autore umano, quest’ultimo deve poter dimostrare che il suo apporto creativo è stato rilevante rispetto all’apporto dato dalla macchina.
Si pone quindi il tema della prova.
L’autore dovrà, in primo luogo, essere in grado di dare prova delle istruzioni (prompt) fornite alla macchina nella fase di creazione dell’opera e quindi organizzare il proprio lavoro di conseguenza. La valutazione dei prompt porterà poi a definire se l’apporto umano è stato determinante in termini di creatività.
L’importanza dei prompt
Il tema dei prompt non si pone, peraltro, solo in relazione alla prova dell’apporto determinante dell’essere umano rispetto all’elaborazione della macchina.
Altra questione, diversa anche se strettamente legata, riguarda l’anteriorità di un’opera rispetto ad un’altra simile sempre creata dalla macchina.
È infatti possibile che un sistema di intelligenza artificiale generi due opere del tutto simili dopo avere ricevuto istruzioni da due autori diversi. Tanto è vero che i maggiori fornitori di sistemi di intelligenza artificiale per fini generali prevedono tale possibilità nelle condizioni generali di contratto che l’utilizzatore accetta, scrivendo chiaramente che, in considerazione delle modalità di addestramento dell’algoritmo, non è possibile escludere che vengano prodotti dalla macchina più risultati, out put, del tutto simili.
Anche in questo caso si pone un tema di prova: l’autore dovrà essere in grado di dimostrare quali istruzioni ha fornito alla macchina e anche di avere ottenuto quel determinato out put per primo.
L’importanza delle condizioni generali di contratto dei fornitori
Rimane, poi, sempre di fondamentale importanza conoscere le condizioni generali di contratto relative a qualunque sistema di AI si abbia intenzione di utilizzare, con particolare attenzione ai sistemi di AI per finalità generali.
In conclusione, il diritto di proprietà intellettuale viene per ora riconosciuto solo ad un essere umano ma solo se questo è in grado di provare che il suo apporto, le istruzioni date alla macchina, sono state determinanti in termini di creatività per l’elaborazione dell’opera.
Rubrica "AI LEGAL, un prisma da comporre"
Leggi gli altri articoli presenti nella nostra rubrica dedicata.
![]() AI e IP Law
AI e IP Law